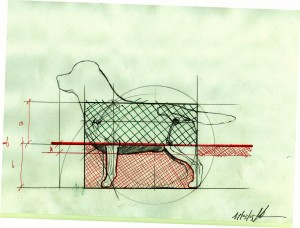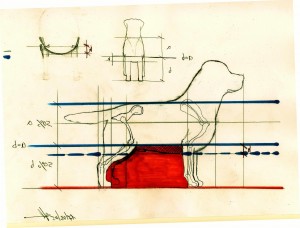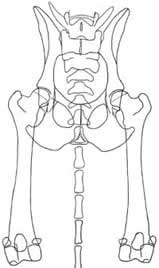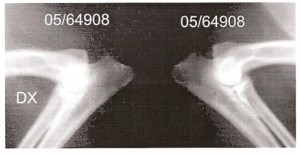7_DISPLASIA DELLE ANCHE E DEI GOMITI di Dott. Ugo Riccò
Quanto
esposto di seguito è tratto dalla esposizione sul argomento, prese in
prestito, dalle Pagine Web del Sito curate del Dott.Veterinario Ugo
Riccò, quale Veterinario che segue l'aspetto sanitario del mio
Allevamento .
|
|
Ambulatorio Veterinario
"Dr. Ugo Riccò"
via Matteotti, 12
46031 Bagnolo San Vito (Mantova)
e-mail: info@ugoricco.com
telefono: +39 0376.415610
fax: +39 0376.251336
cell.: +39 335.324847 |
| www .ugoricco.com |
|
|
|
Dr. Ugo Riccò, Veterinario Referente per:
F.S.A (n° 591): Displasia dell’anca HD e Displasia del gomito ED
Ce.Le.Ma.Sche (n° 558): Displasia dell’anca HD, Displasia del gomito ED, Spondilartrosi SP e Sindrome di Wobbler WS
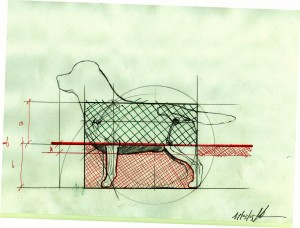

Per
combattere le malattie di origine genetica Allevatori e Veterinari
hanno costituito, da molti anni, a livello mondiale, dei comitati
scientifici per studiare le varie patologie di origine genetica o
ereditarie. In Italia (cosi come negli altri paesi che aderenti alla
F.C.I.) ci sono due società che si occupano di questi problemi, una più
specialistica, e datata, Ce.Le.Ma.Sche. (Centrale di Lettura delle
Malattie Scheletriche ereditarie del cane) che fa capo all’ A.I.V.P.A.
(Associazione Italiana Veterinari per Piccoli Animali), l’altra, più
recente, F.S.A. (Fondazione Salute Animale) che fa capo alla
S.C.I.V.A.C. (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da
Compagnia) ha un taglio più generalistico, in quanto oltre allo studio
delle malattie scheletriche ha tra i suoi scopi lo studio delle altre
patologie di origine genetica.
Attività principale di entrambe
le strutture è quella di formare dei Veterinari Ufficiali, detti anche
Referenti, in grado di raccogliere le informazioni e dati delle varie
patologie, in modo uniforme ed in linea con gli standard internazionali,
elaborati dalle commissioni scientifiche internazionali, sotto la
supervisione dell’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e della
F.C.I. (Federazione Internazionale della Cinofilia).
Per fare
ciò vengono promossi dei corsi specialistici ai quali i veterinari
interessati partecipano, vengono esaminati, ed alla fine se vengono
riconosciuti idonei, vengono nominati “Veterinari Referenti” (per quella
determinata patologia) della società (FSA o Ce.Le.Ma.Sche).
I
“Veterinari Referenti” (o Ufficiali) hanno il compito di esaminare i
soggetti che richiedono l’esenzione per una determinata patologia, sia
essa Displasia dell’Anca, del Gomito, Spondilartrosi, o quant’altro,
raccogliere le informazioni secondo le metodologie e gli standard
internazionali, identificare gli animali soggetti all’esame, e spedire
le informazioni ottenute alla “centrale di lettura” che ha il compito di
emettere un Giudizio Ufficiale ed archiviare le informazioni, elaborare
i dati ed emettere le statistiche.Ogni Veterinario puo essere Referente
per una o entrambe le centrali di lettura.Ogni Veterinario Referente è
identificato, presso la centrale che lo ha accreditato, con un numero
che compare su ogni referto


L’intento
di questa trattazione è dare ai “non addetti ai lavori” alcuni concetti
elementari su che cosa è la displasia dell’anca, è ovvio che per la
complessità dell’argomento, questa trattazione può prestare il fianco a
critiche e puntualizzazioni da parte dei lettori più esperti, che se pur
bene accette, non sono si prestano agli scopi di questo lavoro.
La
displasia dell’anca è una anomalia di formazione e di sviluppo
dell’articolazione coxo-femorale che può essere riscontrata in tutte le
specie di animali domestici ma assume particolare risalto nel cane.
Consiste in una malformazione dell’articolazione coxo-femorale nella sua
componente acetabolare (displasia dell’anca di tipo acetabolare),
femorale (displasia dell’anca di tipo femorale ) o di entrambe le
componenti, ciò produce un’incongruenza tra le superfici articolari con
conseguente alterazione delle stesse; ciò porta inevitabilmente a
malattia degenerativa articolare o artrosi cronica. E’ la malattia
ortopedica di origine non traumatica più diffusa e conosciuta nei cani
di taglia media, grande e gigante (taglie canine in cui la malattia ha
maggior prevalenza e soprattutto si manifesta con maggior gravità). Essa
costituisce la malattia ereditaria del cane che da più anni è stata
oggetto di studi e di programmi di controllo; è stata studiata e
diagnosticata in oltre 150 razze canine.
Le Cause
Questa
è una patologia multifattoriale, ossia numerosi fattori, quali quelli
genetici, ambientali e nutrizionali, entrano in gioco nel suo sviluppo e
nel determinarne la gravità .La displasia dell’anca è considerata una
malattia ereditaria, pur non essendo congenita, con modalità di
trasmissione determinate da numerosi geni,cosa che ne rende difficile
l’identificazione dei soggetti portatori. Ciò significa che la malattia
può essere trasmessa, con modalità ancora non chiarite, da un genitore
ad un discendente, ma non è comunque presente quando il cane nasce
perché la stessa articolazione si conforma durante il periodo della
crescita.Le alterazioni anatomiche poligenetiche si osservano sul
processo di formazione dell’acetabolo, oppure sullo sviluppo dei mezzi
di contenimento, attivi (muscoli del bacino), e passivi (legamento
rotondo e capsula articolare) dell’articolazione coxo-femorale.
Indipendentemente dai fattori ereditari, anche caratteristiche
morfologiche di razza e condizioni endocrine individuali possono
rivestire un ruolo complementare nella genesi della malattia. Tra le
condizioni ambientali, il movimento troppo intenso di cuccioli in rapido
accrescimento, eccessivamente pesanti, tenuti liberi in ambiente
accidentato, può favorire l’aggravamento della condizione patologica.
Anche il sesso dell’animale può condizionare la comparsa della
displasia; nel cane le femmine sono colpite in rapporto 3:1 rispetto ai
maschi, questo è dovuto alla presenza di estrogeni, in quanto la
relaxina determina un rilassamento della capsule articolare. Nei cani
displasici, la cavità acetabolare risulta troppo ampia, poco profonda e
con margini insufficientemente rilevati. Ne risulta una instabilità
della testa del femore nel corso del movimento che, con il progredire
dello sviluppo dell’animale determinano manifestazioni consequenziali di
tipo artrosico. Nei cani con displasia dell’anca, le modalità con cui
si presentano i segni clinici e la loro gravità variano notevolmente da
un soggetto all’altro. Il cane appare comunemente riluttante a muoversi,
perché cerca di proteggere l’articolazione dolente. Si riscontra anche
una modificazione del modo di correre, in quanto l’animale cerca di
proteggere l’articolazione dolente assumendo una nuova andatura, che
richieda minor movimento a livello dell’anca. L’animale può manifestare
un quadro clinico caratterizzato da difficoltà ad alzarsi, a procedere
ad andatura normale e a sdraiarsi, e mostrare dolore in seguito a
manualità sugli arti posteriori.

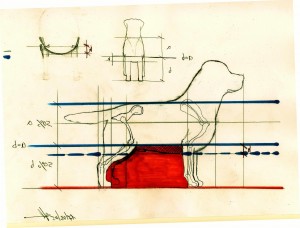
Il controllo della malattia
Non
essendo ancora state identificate le mappe genetiche del cane e quindi
non essendo ancora stati identificati i geni responsabili della malattia
per poter individuare i soggetti portatori, il controllo di queste
razze può essere effettuato oggi solo attraverso lo screening del
fenotipo (ossia come sono fatte le articolazioni) dei riproduttori e di
quanti più parenti possibili. Il controllo del fenotipo, infatti,
avviene attraverso lo studio radiografico delle articolazioni delle
anche e lo studio viene eseguito all’età minima di un anno, per essere
certi che le anche abbiano completato il loro sviluppo. L’età minima
richiesta è di 12 mesi per tutte le razze, eccetto però quelle giganti
(alani, molossi , s. bernardo , terranova , mastino napoletano) per le
quali è di 18 mesi; altra eccezione riguarda razze come Leonberger,
Rottweiler, Briard, Grande bovaro svizzero e Bovaro del Bernese per le
quali l’età è di 15 mesi. Per i soggetti che vengono radiografati ad
un’età superiore si deve tener conto delle modificazioni artosiche
secondarie. L’esame radiografico viene effettuato sul cane anestetizzato
o profondamente sedato e mantenuto in decubito dorsale.
Modalità di controllo della displasia nel mondo
In
tutti i paesi dove la displasia si è sviluppata sono diventati
operativi dei programmi di controllo che, presuppongono dei protocolli
ufficiali tali da rendere accreditate, a livello nazionale ed
internazionale, le certificazioni conseguite. Per la diversità temporale
ed ambientale in cui si sono sviluppate tutte queste esperienze nei
vari paesi del mondo, sono stati utilizzati diversi sistemi per il
controllo e la classificazione della displasia dell’anca ed ancora oggi
sono difficili i confronti tra le certificazioni emesse dai vari paesi e
dalle varie organizzazioni.La Commissione Scientifica della FCI ha
cercato di razionalizzare la classificazione della displasia dell’anca
proponendo una classificazione in cinque gradi (A,B,C,D,E) che è stata
adottata da molte nazioni e che permette comunque un confronto con
quelle utilizzate in altri paesi che hanno mantenuto le loro precedenti
classificazioni. La classificazione della FCI, ulteriormente suddivisa
in sottoclassi (A1, A2; B1, B2; C1, C2; D1, D2; E1, E2) permette un
immediato confronto ed una facile comparazione con le diverse
classificazioni di Stati Uniti d’America, Regno Unito, Finlandia,
Olanda, Svezia e Norvegia.
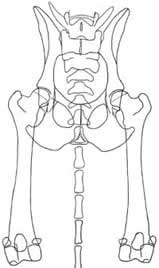

Posizionamento coretto del bacino per l'esecuzione della esenzione ufficiale
Protocollo e classificazione FCI
Le
norme per l’esecuzione e l’interpretazione delle radiografie sono state
formalizzate come riportato di seguito:A) l’età minima per la lettura
dei radiogrammi è di un anno e, per le razze giganti, di un anno e
mezzo.B) i cani devono essere identificati attraverso sistemi di
riconoscimento quali tatuaggi o microchip. La stessa identificazione
deve comparire sul pedigree e sul radiogramma.C) Sul radiogramma deve
comparire il numero di identificazione del soggetto esaminato, la data
in cui è stato effettuato ed il simbolo D ed S che identifichi sulla
radiografia l’anca destra o l’anca sinistra del cane. D) Il proprietario
deve sottoscrivere l’autenticità dell’identità del cane radiografato.
Il proprietario deve inoltre autorizzare il veterinario affinché possa
trattenere la radiografia. Il veterinario deve confermare di aver
verificato l’identità del cane, dichiarare se abbia sottoposto l’animale
a sedazione o ad anestesia e se il cane è stato giudicato
sufficientemente rilassato.E) Le radiografie dovranno essere archiviate
in un archivio centralizzato.F) La diagnosi dovrà essere posta sulla
scorta di almeno una proiezione radiografica ventro-dorsale con le zampe
estese (posizione standard 1). Potrà essere analizzata anche una
seconda radiografia con le zampe flesse (posizione standard 2).G) La
radiografia dovrà avere una misura minima da contenere almeno entrambe
le anche ed entrambe le rotule.H) La qualità tecnica delle radiografie
dovrà consentire una diagnosi accurata dello stato delle anche.I) Se le
regole precedenti non sono rispettate integralmente le radiografie
dovranno essere respinte. J) Le radiografie dovrebbero essere
interpretate da un esperto accreditato o da un gruppo di lettori scelti
dal club di appartenenza del cane radiografato.K) Ogni centrale di
lettura nazionale dovrebbe consentire la possibilità di appello
rivolgendosi alla centrale di lettura del Comitato Scientifico della
FCI.

Radiografia dell'Anca
Descrizione delle classi di displasia
Queste
classi fanno riferimento ai cani di età compresa fra uno e due anni,
sulla scorta della valutazione della proiezione ad arti tesi:A) nessun
segno di displasia (GRADO A): la testa del femore e l’acetabolo sono
congruenti. Il margine acetabolare cranio-laterale appare netto e
leggermente arrotondato. La rima acetabolare è sottile ed uniforme.
L’angolo acetabolare secondo Norberg è di circa 105° o superiore.Nelle
anche giudicabili eccellenti il margine acetabolare cranio-laterale
include la testa del femore ancora di più in direzione latero-caudale.B)
anche quasi normali (GRADO B): la testa del femore e la cavità
acetabolare sono leggermente incongruenti e l’angolo secondo Norberg è
di circa 105°, oppure l’angolo di Norberg è inferiore a 105°, ma il
centro della testa del femore si trova medialmente rispetto al margine
acetabolare dorsale mentre la testa del femore e l’acetabolo sono
congruenti.C) leggera displasia dell’anca (GRADO C):la testa del femore e
l’acetabolo sono incongruenti, l’angolo secondo Norberg è di circa 100°
e/o sussiste un leggero appiattimento del margine cranio-laterale
dell’acetabolo. Sono presenti lievi irregolarità o leggeri segni di
artrosi a carico del margine acetabolare craniale, caudale o dorsale od
in corrispondenza del collo o della testa del femore.D) displasia di
grado medio (GRADO D): è presente un’incongruenza evidente tra testa del
femore e cavità acetabolare con sublussazione. L’angolo acetabolare
secondo Norberg è compreso tra 90 e 100°. Sono presenti segni riferibili
ad osteoartrosi ed è evidente l’appiattimento del margine acetabolare
cranio-laterale.E) displasia grave (GRADO E): sono presenti
modificazioni displastiche evidenti delle articolazioni coxo-femorali
quali lussazione o marcata sublussazione, l’angolo acetabolare secondo
Norberg è minore di 90°, c’è appiattimento del margini acetabolare
craniale, deformazione della testa del femore (testa a fungo,
appiattita) o altri segni di osteoartrosi.Questa classificazione deve
essere fatta sulla scorta del solo referto radiografico e deve essere il
più obiettiva possibile. Lo schema di classificazione può essere
adattato a cani più anziani tenendo in considerazione i segni secondari
di artrosi in relazione all’età del cane.Sono adatti alla riproduzione
solo i soggetti appartenenti alle tre categorie “a”, cioè normale (HD
A), quasi normale (HD B) ed ancora ammesso (HD C) quest’ultimo grado può
non essere ammesso per alcuni club di razza (es. doberman).





Grado di displasia : A-B-C-D-E-
Tratto da:
"DISPLASIE DI SVILUPPO DELL'ANCA E DEL GOMITO NEL BOVARO DEL BERNESE"
Tesi di laurea anno accademico 2000/2001 del dr. Mai Fiorenzo, che si ringrazia per la gentile concessione.


Come difendersi dalla displasia dell'anca
Considerato
che tutte le razze canine, di taglia media, grande e gigante, sono
potenzialmente portatrici di questa patologia, come si fa, se si vuole
acquistare un cane appartenente a queste categorie, ad evitare, o
meglio, a ridurre il rischio di comprare un cucciolo che un domani
potrebbe essere displasico?
I casi sono due: o si acquista un
cucciolo di età superiore ai 6 mesi già radiografato (come fanno quelli
che cercano cani molto pregiati per le esposizioni e la riproduzione)
scelta difficilmente praticabile e molto costosa; oppure si richiedono
cuccioli che vengono da allevamenti che utilizzano per la riproduzione
soggetti selezionati come esenti. Ovviamente, prima di tutto, bisogna
sapere se per la razza che c’interessa viene fatta selezione, per
esempio, se abbiamo deciso di comperare un Pastore Tedesco, un Labrador,
o un Bovaro del Bernese, questi sono sottoposti a selezione, se
decidiamo invece di comperare un Bulldog Inglese, questi assolutamente
non lo sono.
Come si capisce se un soggetto è stato selezionato?
Tutti
i soggetti ammessi alla riproduzione sono stati sottoposti ad un esame
radiografico ufficiale e presentano sul loro certificato genealogico un
timbro della centrale di lettura con la lettera “A” o comunque un
certificato rilasciato dalla F.C.I. (o da una società affiliata: in
Italia Ce.Le.Ma.Sche. e F.S.A.) che attesta l’avvenuto riconoscimento.
Ogni allevatore non ha difficoltà ad esibire i certificati dei genitori
dei cuccioli in vendita. Non è il caso di fidarsi di quegli allevatori
che dicono “non si preoccupi i cani sono a posto” o “glielo assicuro io,
in trent’anni che allevo non ho mai visto un cane displasico” (perché
se una cosa non la cerchi è sicuro che non la trovi); oppure esibiscono
certificati non ufficiali (anche se redatti da un veterinario). E’
sempre bene tener presente che non è il cucciolo di tre mesi che
acquistiamo che è esente da displasia, ma lo sono i suoi genitori, è
quindi può anche capitare che da due supercampioni possa, a volte,
nascere un cucciolo displasico e purtroppo l’allevatore non può saperlo
prima, ma può solo risarcirvi il cucciolo.
Come si fa a sapere che il soggetto scelto non è displasico?
Purtroppo
non è ancora possibile al momento della vendita (che di solito avviene a
2 o 3 mesi) capire se il soggetto in questione svilupperà, o meno, la
patologia. Non è in grado l’allevatore, non è in grado il veterinario, e
nemmeno l’acquirente. Per cui bisogna
portarsi casa il cane
tenendo ben presente che il cucciolo appartiene ad una razza
potenzialmente displasica. Diventa così indispensabile seguire le
indicazioni che l’allevatore da (a voce o per iscritto) per una buona
cura e manutenzione del cucciolo, specialmente attenendosi ai consigli
nutrizionali, per i quali va in ogni caso consultato anche un
Veterinario.
Una corretta nutrizione ed una corretta curva di
crescita consentono al cucciolo di limitare notevolmente l’aggravarsi
d’eventuali lesioni di cui potrebbe essere portatore.Per esempio: se un
cucciolo è geneticamente destinato ad avere un giudizio HD “C” (che lo
ammette lo stesso alla riproduzione), con una scorretta alimentazione,
peso eccessivo (specialmente nelle razze a rapido accrescimento), e
attività motoria inadeguata, il suo giudizio al momento della
determinazione ufficiale può essere “D” o peggiore, quindi essere
escluso dalla riproduzione.
Eseguire sempre una o più
radiografie di controllo durante la crescita del cane, qui è il Medico
Veterinario che deve indirizzarvi verso il più corretto modo di
procedere, in modo da venire a conoscenza il più precocemente possibile
di eventuali problemi, ed attuare le strategie più adatte al caso.
Generalmente la prassi è quella di eseguire la prima radiografia ad
un’età non inferiore ai 6 mesi, ma le forme più gravi possono essere
diagnosticate già all’età di 4 o addirittura di 3 mesi; è sempre bene
attrezzarsi per tempo.

Ho un cane displasico, adesso che faccio?
La
gestione di un cane displasico è un argomento delicato, ma non
drammatico, che va sempre trattato con il proprio Veterinario di fiducia
il quale potrà proporre le varie alternative terapeutiche a
disposizione a seconda della gravità della patologia, la razza,
l’attitudine, l’indole ed il valore del cane. Non dimeno vanno tenute in
considerazione la sensibilità e la disponibilità economica del
proprietario, anche perché certe volte vengono consigliati degli
interventi che possono superare di gran lunga il valore commerciale del
cane e non sempre sono indispensabili per garantire una vita
etologicamente soddisfacente al cane. Il consiglio che troppo spesso
viene dato: “che cosa le interessa del costo, tanto dopo si fa risarcire
dall’allevatore” non sempre, anzi raramente, ha maturato i frutti
sperati.
Vediamo ora per sommi capi quali sono le diverse opzioni terapeutiche:
1)Protesi
totale d’anca: si tratta della sostituzione in toto dell’articolazione
coxo-femprale; consiste nell’asportazione della testa del femore e
dell’escavazione dell’acetabolo. L’articolazione è sostituita con una
protesi in acciaio e teflon. Si può effettuare su tutti i soggetti,
anche con lesioni artrosiche gravi in stato avanzato. La funzionalità
dell’articolazione è completamente ripristinata ed il dolore è eliminato
totalmente. E’ un intervento praticato raramente in quanto necessita
un’altissima preparazione professionale, una eccellente dotazione
strumentale ed è di difficile gestione del periodo post operatorio, il
costo è molto elevato e frequenti sono i casi di danneggiamento della
protesi (il cane non conosce l’uso delle stampelle, e quando vede un
gatto non sta a pensare alle sue protesi).

2)Triplice
Osteotomia Pelvica: é un intervento complesso che ha come scopo
ristabilire la congruenza tra la testa del femore e la cavità
acetabolare stimolandone un accrescimento corretto dell’articolazione.
La tecnica prevede la resezione delle tre branche del coxale, in modo da
liberare l’acetabolo dai vincoli con il resto del bacino, facendolo
così ruotare in modo tale da ricoprire nuovamente la testa del femore,
in seguito l’acetabolo è stabilizzato nella sua nuova posizione da una
particolare placca con viti che lo collega alla branca iliaca, le altre
due branche (pubica ed ischiatica) si salderanno da sole in seguito . E’
l’intervento più praticato necessita di una alta preparazione
professionale, una buona dotazione strumentale, il postoperatorio non
presenta eccessive difficoltà gestionali. Tra le sue limitazioni
elenchiamo l’età del cane, si può fare solo su soggetti abbastanza
giovani, che non abbiano terminato lo sviluppo acetabolare, non
presentano alterazione morfologica della testa e dell’acetabolo tali da
precluderne la congruità, in fine non abbiano ancora sviluppato lesioni
artosiche secondarie. Anche in questo caso il costo dell’intervento può
essere un fattore limitante.

3)Tettoplastica
acerabolare: questo intervento (meno invasivo dei precedenti) ha come
scopo di allungare il margine dorsale dell’acetabolo in modo da fornire
un maggiore appoggio sulla testa del femore. Viene effettuato mediante
un prelievo di “listelli” ossei dall’ala dell’ileo che verranno infissi a
palizzata in alcuni fori predisposti sul margine acetabolare dorsale.
Da buoni risultati nel migliorare la deambulazione e diminuire il
dolore.
4)Sinfisiodesi pubica: questa tecnica si basa sul
principio di bloccare l’accrescimento del bacino a livello del della
sinfisi pubica, l’accrescimento mantenuto a livello della sinfisi sacro
iliaca provocherà una rotazione verso l’esterno del margine acetabolare
dorsale in modo da portarlo ad una maggiore copertura della testa del
femore. La tecnica da i migliori risultati se applicata su cani molto
giovani, 3-4 mesi al massimo, su cani più anziani i risultati sono
mediocri in virtù dell’ormai consolidato accrescimento del bacino,
inoltre è nuova ed i risultati sono ancora fonte di discussione nella
comunità scientifica.La particolarità di questa tecnica è che
l’intervento non lascia traccia sull’animale adulto ciò apre la porta
anche a considerazioni etico-professionali, in quanto è migliorativa del
giudizio finale del soggetto operato, il quale potrebbe anche essere
ammesso alla riproduzione non avendone le caratteristiche genotipiche.

5)Ostectomia
della testa del femore: prevede l’asportazione della testa del femore
allo scopo di alleviare il dolore dell’artrosi il cane anche senza teste
è in grado di camminare ugualmente, anche se con incedere non
perfettamente saldo, e condurre uno stile di vita più che accettabile.
E’ un intervento semplice e dai costi contenuti, si attua su quei cani
che presentano gravi problemi deambulatori legati al dolore
dell’articolazione. E’ l’intervento più praticato.

6)Pettineotomia:
è un reperto archeologico della chirurgia, si praticava quando parecchi
anni fa vi era la convinzione che una delle cause della displasia
dell’anca fosse una contrattura, o un mancato sviluppo del muscolo
pettineo (quel muscolo cordoniforme che sta al centro del piatto interno
della coscia). Con la sua resezione si riteneva di annullare una forza
che tendeva ad estrarre la testa del femore dall’acetabolo. Non è da
fare!
7)Terapia medica conservativa: non tutti i cani con
displasia dell’anca devono o possono per forza essere operati, molti
soggetti clinicamente manifesti, anche con gravi sintomi (deambulazione
ridotta, riluttanza a stare in piedi e al movimento), rispondono in modo
eccellente alla terapia con anti infiammatori non seroidei (FANS). In
medicina veterinaria, abbiamo ora a disposizione, nuove molecole con
elevata efficacia ed effetti collaterali ridotti al minimo (CARPROFEN e
MELOXICAM), che adiuvati da integratori alimentari di nuova concezione,
sono in grado di ridurre la sintomatologia algica ed in alcuni casi di
riparare le cartilagini distrutte durante le varie fasi del processo
infiammatorio. Emblematico il caso di questo labrador che mi è stato
portato alla visita non più in grado di camminare giacché le anche,
entrambe lussate, gli provocavano grave dolore alla minima
manipolazione, la muscolatura ormai gravemente ipotrofica non garantiva
più la stazione quadrupedale. Con tre mesi di terapia antinfiammatoria e
condrotrofica, moderato esercizio fisico ed alimentazione equilibrata,
il cane pur dimostrando un peggioramento del quadro radiologico (già
disastroso all'inizio) ha riacquistato la funzionalità deambulatoria,
nel giro di un anno la capacità deambulatoria era tornata normale e cosi
anche il trofismo muscolare, potendo anche saltare su e giù dalla
macchina, fare le scale, e rincorrere la pallina. Tuttora sta facendo
una vita normale.

Radiografia delle anche di un Labrador Retriever con una situazione drammatica curata con scelte alternative
In
conclusione la displasia dell'anca è una patologia seria ma non
drammatica, complessa, di difficile eradicazione dalle razze canine che
colpisce (a meno che non si voglia snaturare la morfologia dei
soggetti). Gli Allevatori ed i Veterinari Ufficiali coalizzano il loro
sforzi per ridurne il più possibile l'incidenza nella popolazione. Chi
acquista un cane, deve essere conscio di questa situazione e a sua volta
collaborare con i primi nel fare progredire la ricerca nei confronti di
questa patologia. Ciò che frena maggiormente la ricerca è la scarsa
collaborazione degli acquirenti che cercano tutte le garanzie possibili
al momento dell'acquisto, ma poi si dimenticano di fare la loro parte
per ottenere previsioni sempre più attendibili.
Mi
spiego meglio: ogni allevatore quando vende un cucciolo, prega ed
implora l'acquirente di portarlo, alle età prestabilite, a fare i
controlli radiografici. Perché? perché il modo migliore per valutare un
riproduttore non è valutare solo le sue articolazioni, ma valutare il
numero più alto possibile dei suoi figli. Questo parametro si chiama
affidabilità riproduttiva ed è l'unico che da con certezza la capacità
riproduttiva di uno stallone. Più figli sono radiografati più affidabile
è il giudizio di quello stallone o quella fattrice. Se noi dobbiamo
scegliere da chi fare coprire la nostra cagna, per ottenere cuccioli
sicuramente non displasici, che stallone dobbiamo scegliere? uno
stallone con giudizio "A" che ha fatto cento figli e solo tre o quatto
sono stati radiografati ufficialmente con giudizio "A"; o uno stallone
con giudizio "B" che a fatto cento figli di cui novanta radiografati con
giudizio "B"? Io sceglierei il secondo che è il più affidabile.Questo
lo posso fare solo se i vari proprietari dei cuccioli di un determinato
stallone si sono presi la briga di fare le radiografie ufficiali. Il più
delle volte questo non capita e gli allevatori sono obbligati a coprire
con stalloni che non hanno il grado di attendibilità desiderato; perché
chi acquista il cane per la casa ed il giardino non s’interessa di
questi problemi, e di quel cane non sene sa più niente bello o brutto
che sia, salvo però ripresentarsi pieno di pretese se qualcosa non va.

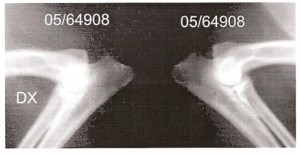
Grado A Grado 0:0
Quindi per avere un cane non displasico le cose da fare sono essenzialmente tre:
1) Conoscere la patologia.
2) Affidarsi a professionisti seri e preparati.
3) Collaborare con loro per lo sviluppo della razza che tanto si ama, tanto da spendere tanti soldi per acquistare un esemplare.
.............. a, dimenticavo
4) Un po’ di cu..... fortuna, non guasta!